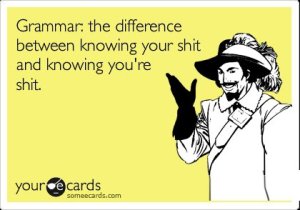Prima di Hiroshima avevo parlato del Giappone qui, qui e qui.
Dopo Hiroshima invece penso proprio che il mio reportage possa considerarsi concluso.
In effetti Hiroshima è stata la prima città che abbiamo visitato, perché siamo sbarcati a Osaka, ma appena il tempo di mettere piede in albergo, eravamo già alla stazione per una gita fuori porta a Nara, che è a circa 30 chilometri, e la mattina dopo siamo ripartiti di buon mattino.
La nostra destinazione finale era Myajima, che è un’isoletta del Giappone meridionale. Ma siccome il ferry per raggiungerla si prende a Hiroshima, ci è sembrata una buona idea farci un giro per un paio di orette.
Adesso che è passato più di un mese faccio una certa fatica a rievocare esattamente quell’atmosfera, perché appena scendi dal bus e cominci ad attraversare il parco in fondo al quale si può visitare il Peace Memorial Museum, ti prende come una strana sensazione che potrebbe essere naturale oppure indotta, questo non posso dirlo, ma che comunque altera in qualche modo il peso del ricordo che puoi avere di un posto così.
Del resto la prima cosa che vedi, proprio all’imboccatura del parco, è questa:

L’hanno lasciata com’era. L’unica cosa che rimase in piedi. Se, come me, sei nato in una città come Roma, dove le rovine sono il pane e il companatico, di primo acchitto rilevi una strana similitudine formale: l’immagine della rovina protetta da un cancello con l’edera che cresce sulle pareti circondata da un praticello verde e curatissimo ti è familiare. L’Hiroshima Dome o il foro di Traiano, per dire. Che differenza c’è? A parte il fatto che a Roma il praticello col cazzo che è curatissimo, intendo. Concettualmente si assomigliano. C’è solo un impercettibile brivido che lì per lì non riconosci neppure. Lo provi, e non lo sai. Che dice: no. Non sono proprio esattamente la stessa cosa. Però diciamoci la verità, all’inizio davvero quasi non ci fai nemmeno caso.
Poi attraversi tutto il parco, se hai voglia te lo giri, e altrimenti punti dritto al museo. Noi l’abbiamo girato perché essenzialmente, tra me e mio marito, sommiamo in due il senso di orientamento di un lemure sbronzo e dopato, per cui in buona sostanza ci siamo persi. Dopodiché, seguendo il flusso, se Dio vuole abbiamo individuato la sagoma grigia e allungata del Memorial, e ci siamo fiondati lì.
Mentre vagolavamo tra i cespugli nella speranza di capire in che direzione muoversi, mi sono imbattuta in questa curiosa indicazione, che ho fotografato:

L’ho trovata un pochino surreale, in modo tragico e poetico insieme. Esseri nati a Hiorshima, e preoccuparsi dei danni che possono fare le colombe – con tutto il loro portato simbolico – ammetterete che suona davvero strano.
Ma insomma alla fine siamo entrati nel Memorial. Che è gratuito, una cosa che mi è sembrata straordinariamente giusta, anche se non ci avrei trovato nulla di strano nell’ipotesi contraria. La struttura è a due piani. Tra il primo e secondo c’è un’area in cui puoi sederti. Forse c’è anche un bar ma non ci ho fatto troppo caso, perché lì dentro l’esigenza di riposare prende il sopravvento su qualsiasi altro impulso di base. Riposare non dalla fatica, ché non è il Louvre. Riposare dalla testimonianza puntuale e metodica dell’orrore che il cuore umano può contenere. Perché è questo che vedi lì, e lo vedi senza nessuna retorica barocca. Un orrore in prosa, quasi scientifico. Non c’è patetismo né voglia di titillare miserabili istinti pulp. Non occorre. Ti dicono le cose come stanno, e se poi a restare in piedi non ce la fai, ti offrono anche una sediolina per evitarti l’imbarazzo di un patetico mancamento. Patetico per te, ma soprattutto per loro, che com’è noto non sono un popolo che ama il sovraccarico emozionale né le sceneggiate napoletane.
Forse quello che ti devasta di più in tutto questo non è nemmeno il resoconto degli effetti, che pure c’è, ed è puntuale. È la cognizione che non è accaduto a caso, ma è stato pensato, voluto, organizzato con metodo. Un obiettivo militare scelto al posto di altri, cartina alla mano, perché, per esempio, non c’erano prigionieri americani in zona. L’idea che uomini e donne abbiamo potuto sedere a un tavolo e progettarlo prima che accadesse, quando ancora sarebbe stato possibile evitarlo. L’idea di un capo di stato capace di pensare che fosse necessario. Ecco, è questo che ti costringe a sedere sulla tua sediolina e a guardare fuori dalla finestra per un po’. Perché d’improvviso l’appartenenza alla razza umana, la condivisione degli impulsi biologici di base con quel genere di persone, ti risulta intollerabile. È il male dentro di te. Qualcosa che vorresti estirpare. Così radicata e profonda è la sensazione del lato oscuro, che non puoi evitare di pensare che una parte di responsabilità ce l’hai anche tu. Che in condizioni analoghe, in epoche altrettanto incerte e pericolose, magari qualcuno avrebbe potuto convincere anche te della necessità di un epilogo del genere. E questo ti schianta. Ti riduce un mollusco. Ti fa uscire a stento da quell’edificio. Di sicuro, non ti permette di dimenticarlo.
Alla fine, nella straordinaria imprevedibilità del caso che è così spesso portatore di grazia, specie quando non te lo aspetti, la vita ha steso un tappeto di impercettibile letizia davanti ai nostri passi. Mentre attraversavamo il parco a ritroso per tornare alla stazione, siamo stati fermati circa duecento milioni di volte da gruppetti di studenti in divisa fra gli 8 e i 12 anni. C’era sempre un capobanda col quadernetto in mano tipo messale, che con aria cerimoniale compitava frasi del tipo: goodmorning sir, goodmorning madame, may I ask you a question? mentre i compagnucci – bande di 8 o 10 ragazzini – si accalcavano alle sue spalle e crepavano di ridarella con le mani a coprire le bocca.
Io e mio marito abbiamo giocato graziosamente alla Queen Elisabeth e Prince Consort, e chinando il capo ci siamo prestati al gioco rispondendo a tutte le domande, e attendendo con pazienza mentre le nostre impressioni venivano trascritte con acribia sullo stesso quadernino dopo accesa consultazione su ortografia e pronuncia.
Quando ci ha bloccati il quarto commando di minorenni consecutivo, abbiamo seriamente temuto di non riuscire più a tornare al treno, ma abbiamo tenuto duro. E non ci saremmo persi l’esperienza per tutto l’oro del mondo.
Alla fine di ogni intervista – così prevede il protocollo che si è svolto nello stesso identico modo anche in altre città giapponesi – abbiamo anche ricevuto un gentile omaggio per il disturbo. Un origami a forma di cigno. Li abbiamo conservati. Verde quello di mio marito, e giallo il mio.
Fra quei bambini straordinariamente sorridenti e cortesi, così potenti nella verità della loro bellezza, c’era quasi sicuramente qualche lontano bis o trisnipote nel Mostro. C’era per forza, è un’ovvietà geografica. Mi è parso un bel segnale, forte e chiaro come quello che avevo ricevuto dentro il Memorial, anche se di segno opposto. C’è sempre qualcosa che fa da contrappeso al male. Qualcosa di uguale potenza, profondità e rigore. Nel mezzo, esattamente equidistanti, ci siamo noi. Io, voi, tutti. Ognuno sceglie da che parte desidera guardare. La distanza da entrambi i poli rimane identica. Anche la speranza concreta di felicità. Quello che cambia è il cuore. Perché l’unica cosa che fa la differenza – al netto di ogni gioia e dolore che siamo destinati a provare – è la forma che assume a seconda dell’orizzonte che decidi di chiamare mio.